- Home
- IL CENTRO Apri sottomenù
- RICERCA Apri sottomenù
- PUBBLICAZIONI Apri sottomenù
-
EVENTI
Apri sottomenù
- Le stagioni dell’erudizione e le generazioni degli eruditi. Una storia europea (secoli XV-XIX)
- Libri e lettori nella Bologna dei papi (1506-1796)
- Pagine benedettine
- Dante e la Divina Commedia in Emilia-Romagna
- Con ogni diligenza corretto e stampato. Stampatori, librai e cartari a Faenza dal XV al XVIII secolo
- Lucretia Estensis de Borgia. Tra biografia e narrazione nelle carte dell'Archivio di Stato di Modena
- ITINERARI BIBLIOGRAFICI Apri sottomenù
- Agenda
- Contatti
- Fotogallery
Chi siamo
Le ricercatrici e i ricercatori del Centro di Ricerca in Bibliografia.

Paolo Tinti
Responsabile scientifico
Diplomato presso la Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari di Roma (2003), ha conseguito il Dottorato di Ricerca Internazionale all'Università di Firenze (2007). Dirige il CERB Centro di Ricerca in Bibliografia, costituito presso il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, ed è membro dei Comitati Scientifici della Biblioteca di Discipline Umanistiche e della Biblioteca "E. Raimondi" dell'Università di Bologna.
Appartiene al collegio del Dottorato di ricerca in Scienze documentarie, filologiche, linguistiche e letterarie, curriculum di Scienze librarie e documentarie (Sapienza Università di Roma).
Consulente per biblioteche pubbliche e private, è condirettore della rivista internazionale «TECA: Testimonianze, Editoria, Cultura, Arte». Nel 2015 ha fondato il Centro Studi Abbazia di San Pietro, Modena, per lo studio e la valorizzazione del patrimonio librario e documentario del cenobio benedettino.
Professore aggregato dall'a.a. 2006/07 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, vi ha insegnato Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia ed ha tenuto Laboratori all'interno di corsi di laurea triennali e magistrali.. Tra settembre 2012 e febbraio 2013 è stato visiting professor all'Università di Salamanca (Spagna). Tiene lezioni in università italiane e straniere.
Funge da referee per articoli di riviste scientifiche e per conto di Scuole di Dottorato, in Italia e in Europa.
Ha curato cataloghi di fondi librari antichi e condotto ricerche di storia delle biblioteche dall'Umanesimo al Novecento. Si interessa alla storia del libro e dell'editoria. Si è occupato, inoltre, di aspetti della biblioteconomia, con predilezione per la teoria e la tecnica dei cataloghi e per la valorizzazione dei fondi antichi. Collabora con le principali riviste italiane e straniere del settore.
È tra i membri fondatori della Società Italiana di Scienze Bibliografiche e Biblioteconomiche (SISBB), Roma, dove è revisore dei conti.
Presidente della Sezione Emilia-Romagna dell'AIB dal 2023, Associazione Italiana Biblioteche, di cui è socio dal 1997 e, dal 2013, associato ai sensi della legge 4/2013. Socio corrispondente della Deputazione di storia patria per le antiche province modenesi, della Deputazione di storia patria per le province di Romagna di Bologna, della Accademia Pascoliana, della Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena; socio ordinario della Bibliographical Society di Londra e della SEMYR, Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas, Salamanca.

Gian Mario Anselmi
Già professore ordinario di Letteratura italiana e Letteratura italiana medievale all'Università di Bologna presso il Dipartimento di Filologia classica e Italianistica. Dal 2002 al 2008 e dal 2010 al 2015 è stato direttore del Dipartimento di Italianistica, divenuto dal 2012 Dipartimento di Filologia classica e Italianistica. È tra i fondatori e condirettori di riviste letterarie online ad ampia diffusione internazionale: Griseldaonline, Ossigeno nascente: atlante dei poeti italiani contemporanei, DNA Camporesi. Socio di diverse istituzioni culturali, tra cui l'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, è stato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana Treccani, presidente della Fondazione Gramsci Emilia-Romagna, presidente del Centro di Studi Alfieriani in Asti nonché segretario per due mandati dell'ADI (Associazione degli Italianisti italiani). È membro del Consiglio di amministrazione della Biblioteca Classense di Ravenna. Tra i suoi interessi, la cultura medievale (fra cui spiccano diversi e importanti contributi danteschi), la letteratura umanistica e rinascimentale (ha curato, tra l'altro, le principali opere di Niccolò Machiavelli, di cui è tra i maggiori esperti), la cultura e l'arte del Settecento, la storia della storiografia, la periodizzazione della letteratura, la letteratura comparata, la storia della critica, la didattica della letteratura con la curatela di fortunati manuali e antologie. Ha collaborato, con vari saggi, alla Letteratura italiana edita da Einaudi e diretta da Alberto Asor Rosa. Ha fatto parte del Comitato direttivo dell'Enciclopedia Machiavelli Treccani per la quale, fra l'altro, ha redatto la voce dedicata al Principe. Ha curato per Bollati Boringhieri e Mursia l'edizione delle opere principali di Machiavelli e Guicciardini. Ha coordinato per l'Edizione Nazionale delle Opere di Machiavelli, presso la casa editrice Salerno, i volumi dedicati alle Istorie Fiorentine e agli scritti storici. Ha tenuto corsi e conferenze in molti paesi europei ed extraeuropei e suoi lavori sono stati tradotti in varie lingue.

Anna Bernabè
Laureata in Lettere presso l’Università di Bologna con tesi in Biblioteconomia e bibliografia, ha partecipato al progetto di ricerca nazionale COFIN 2003 Oltre il testo. Dinamiche storiche paratestuali nel processo tipografico-editoriale in Italia. Dal 2005 al 2024 è stata bibliotecaria presso l’Università di Ferrara, dove si è occupta in particolare della gestione dei fondi speciali conservati nelle biblioteche dell’Ateneo, in base anche alle competenze acquisite grazie ai master universitari in Restauro e caratterizzazione di opere manoscritte e libri a stampa in Antico Regime Tipografico (Università di Bologna, 2006) ed in Cultural management (Università di Ferrara, 2016). Dal 2024 è funzionario bibliotecario presso la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Emilia Romagna.
Dal 2018 è membro del comitato di redazione della rivista "TECA" e collabora ad alcune attività della cattedra di Bibliografia, Storia del libro e biblioteconomia, e Storia delle biblioteche dell’Università di Bologna. Cultrice della materia M-STO/08 Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia (2021) e PhD in Culture Letterarie e Filologiche (2022) presso l’Università di Bologna, i suoi interessi di ricerca riguardano la valorizzazione del patrimonio storico e dei fondi speciali nelle biblioteche degli atenei, in particolare nella prospettiva della Terza Missione e con attenzione al settore delle Digital Humanities.

Ilaria Bortolotti
Dopo la Laurea Magistrale in Italianistica presso l’Università di Bologna con una tesi sulla biblioteca di Luigi Ferdinando Marsili (1658-1730), ha proseguito le sue ricerche sullo scienziato e mecenate bolognese durante il dottorato in Studi Storici e Documentari dell’Università di Milano, conseguendo il titolo di dottore di ricerca a gennaio 2017. La sua tesi ricostruisce la rete epistolare internazionale di Marsili, con particolare attenzione ai suoi rapporti con le professionalità legate alla stampa e al commercio librario.
Ha partecipato a seminari e convegni internazionali, tra cui «Straniero in patria. Luigi Ferdinando Marsili a Bologna» (19 novembre 2021, Accademia delle Scienze, Bologna).
Dal 2018 al 2025 è stata responsabile di una biblioteca di pubblica lettura del Comune di Bologna e si è occupata, in particolare, di progetti in ambito di welfare culturale e accessibilità del servizio bibliotecario e dello sviluppo di un archivio di comunità, organizzando una giornata di studi dal titolo «Storie di archivi, storie di comunità» (9 giugno 2023, Biblioteca Luigi Spina, Bologna).
Dal 2025 è in servizio presso l'Area patrimonio culturale dell'Università di Bologna, settore Biblioteca Universitaria.

Jacopo Arnoldo Bovino
Dottorando di ricerca in Culture letterarie e filologiche presso l’Università di Bologna con il progetto dal titolo Il paratesto nei reference books specialistici per le scienze naturali nella prima età moderna. Laureato alla Sapienza Università di Roma, ha discusso con Gianfranco Crupi una tesi in Storia del libro antico a stampa sull’opera di Giovanni Paolo Gallucci (1538-1621).
I suoi interessi di ricerca comprendono la storia del libro scientifico e geografico della prima età moderna, la storia della cultura tipografica e della bibliografia. Ha contribuito alla redazione del catalogo della mostra Mirabilia da sfogliare. Libri d’artista dalla collezione di Maria Gioia Tavoni (Pendragon, 2024) ed è autore di articoli e recensioni pubblicati in riviste scientifiche di settore. Nel 2025 è stato visiting scholar presso l’American Geographical Society Library della University of Wisconsin-Milwaukee.
Attualmente si occupa della produzione a stampa incunabolistica di materia cosmografica e periegetica, nonché sulla stampa del Cinquecento veneziano lavorando agli annali tipografici di Francesco Marcolini, in collaborazione con Paolo Temeroli.
Dal 2024 è Journal manager della rivista accademica «Teca», dedicata alle discipline bibliografiche e biblioteconomiche e alla storia della cultura scritta e dallo stesso anno è iscritto all’Associazione italiana biblioteche, incluso nell'Elenco professionale dei bibliotecari italiani (n. E/2024/3612).

Anna Giulia Cavagna
Allegato [89Kb .pdf]
Già Professore Ordinario di Storia del libro e dell'editoria all'Università di Genova, con una laurea in Lettere Moderne, un Dottorato in Storia sociale Europea e un diploma di Archivistica e Paleografia, ha insegnato Bibliografia e Storia del libro anche all'Università di Udine.
Si dedica allo studio e analisi del panorama editoriale e intellettuale europeo della prima età moderna, indagandone strutture produttive, dinamiche geografiche, economiche, distributive. Studia le forme di aggregazione e rielaborazione personale dei contenuti tipografici che si concretizzano nelle biblioteche private. Ha recentemente pubblicato indagini sulla tipografia in spagnolo in Liguria e, stimolata dalla partecipazione alle attività del CERB, ha indagato i rapporti librari d’antico regime fra Bologna e la Liguria con una ricerca sulla secolare interconnessa produzione libraria dei due centri e i fruitori della medesima. Il progetto di lunga durata, ancora in corso, sulla cinquecentesca biblioteca dispersa Del Carretto si è arricchito di un ulteriore contributo sui rapporti politici e le manifestazioni librarie del proprietario e di alcuni suoi famigliari, operativi in Francia in ruoli di rilievo.
Ha partecipato a seminari e convegni in Italia e all’estero, ottenendo borse di ricerca dalla August Herzog Bibliothek e dalla Bibliographical Society, collaborando a progetti nazionali sulla storia della circolazione del libro e dell’editoria. Tra i suoi lavori, l'edizione critica dell'inedito manuale tipografico di Niccolò Capaci e la monografia sulla biblioteca cinquecentesca di Alfonso II Del Carretto marchese di Finale (2011), con l'edizione del relativo catalogo manoscritto. Ha collaborato o collabora con attività di recensione o peer review per riviste scientifiche del settore («Il Bibliotecario», «Bibliothecae.it» «Paratesto», «TECA», «l’Almanacco Bibliografico», «The Library. Transaction of the Bibliographical Society» «The Papers of the Bibliographical Society of America», «Italian Studies» (Oxford), «Giornale Storico della Letteratura Italiana», «Fabbrica del Libro», «La Bibliofilia»).

Loredana Chines
Professoressa ordinaria dal 2016, insegna Letteratura italiana e Letteratura e Filologia medievale e umanistica presso l’Università degli Studi di Bologna, dove è stata, dal 2017 al 2020, tra i componenti del Panel per l'Area 10 della Commissione per la valutazione della Ricerca di Ateneo (VRA).
Le sue principali tematiche di ricerca riguardano Petrarca, la letteratura medievale umanistica e rinascimentale, in particolare la tradizione del commento ai classici, con un’attenzione ermeneutica ed esegetica alla prassi didattica della letteratura italiana e approfondimenti sull’umanesimo bolognese. I suoi studi si nutrono della stretta connessione tra filologia e critica, facendo dialogare il testo letterario con le altre discipline, in primo luogo con le arti figurative.
È condirettrice della rivista internazionale “Ecdotica”, nonché di diverse collane quali “Cultura umanistica e saperi moderni” (Pàtron), “Arezzo e Certaldo” (Antenore), “Letteratura Italiana. Saggi e Strumenti” (Franco Angeli).
È responsabile scientifica del Centro di ricerca A.R.C.E. (Archivio Ricerche Carteggi Estensi), che ha sede nel Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università di Bologna
È nel comitato scientifico delle collane «Filologia e Letterature italiane. Studi e testi», delle Edizioni dell'Orso di Alessandria, e «DUABUS ANCORIS» (diretta da Davide Canfora e pubblicata dalla casa editrice Aragno) e delle riviste specializzate «Archivum mentis» e «TECA»; collabora con vari periodici fra cui “Studi e problemi di critica testuale” e con le case editrici Bruno Mondadori, Einaudi, Carocci, Treccani.

Francesca Florimbii
Professoressa associata presso il Dipartimento di Filologia classica e Italianistica (FICLIT) dell'Università di Bologna, fa parte del CdA della Treccani. I suoi principali interessi di ricerca si rivolgono alla filologia del testo, alla filologia delle fonti e alla filologia d’autore otto-novecentesca (con particolare riguardo per l'opera di Giovanni Pascoli), nonché allo studio della ricezione e della tradizione letteraria italiana e alle questioni di metodo nell’edizione dei carteggi moderni e contemporanei. È membro della Società dei Filologi della Letteratura Italiana (SFLI), dell'Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI), è Socia Residente della Commissione per i Testi di Lingua, è Accademica corrispondente dell’Accademia Pascoliana di San Mauro Pascoli e dell'Accademia dei Sepolti di Volterra. Ha coordinato e coordina l'unità bolognese dei PRIN 2017 e 2020 Petrarca online e fa parte del Comitato scientifico dell'Edizione Nazionale delle Opere di Giosue Carducci. Tra le pubblicazioni, le edizioni critiche delle Chiose e annotazioni ai Trionfi di Petrarca di Giosue Carducci (2022) e degli Amorosi versi di Giovanni Antonio Romanello (2019), l’edizione del carteggio Pascoli – Caselli (2008 e 2010), diversi saggi sul Pascoli dantista e sui Triumphi di Petrarca.
Nato nel 2017 dalla collaborazione tra il Dipartimento di Filologia classica e Italianistica (FICLIT) e la Biblioteca Civica ‘Romolo Spezoli’ di Fermo, il centro (Responsabile scientifico Francesca Florimbii) promuove lo studio del Fondo intitolato a Giuseppe Fracassetti (1802-1883). Il complesso fermano – articolato in archivio e biblioteca, cui si accompagna una ricca miscellanea di opuscoli – raccoglie una considerevole ricchezza di documenti eterogenei, editi e inediti, in gran parte mai consultati, appartenuti al traduttore e al figlio Camillo (1839-1908). Il centro ha sinora promosso varie attività di indagine del patrimonio, a partire dagli autografi di Fracassetti testimoni degli studi su Petrarca e, più in generale, dai manoscritti a matrice letteraria. Di recente, nell’ambito del PRIN 2022 Petrarca Online, è stata realizzata la schedatura dell’intera collezione dell’archivio dedicata a Petrarca, che sarà presto riversata sul portale Manus Online. Sul materiale del Fondo sono poi state condotte numerose tesi di Laurea triennale, magistrale e di Dottorato, che hanno avuto come oggetto d’indagine da un lato l’attività di Fracassetti traduttore dalle letterature antiche e moderne – in molti casi consegnata a saggi che non lasciarono mai lo scrittoio dell’autore –; dall’altro la corrispondenza di argomento letterario dello studioso. Il 17 marzo 2022 si è tenuta presso il Dipartimento FICLIT dell’Università di Bologna la Giornata di studi Testi, carteggi e metadati: il caso Fracassetti, dedicata alla presentazione dei cantieri di ricerca in corso. Gli Atti dell’incontro sono consultabili su AMSActa: https://amsacta.unibo.it/id/eprint/7611/.

Federico Olmi
Bibliotecario e archivista, si è formato alla cattedra della professoressa Maria Gioia Tavoni. Si occupa di storia della bibliografia e delle biblioteche.
Ha curato l’edizione del manoscritto del Catalogo ragionato dei libri dell’abate Gaetano Fantuzzi, primo bibliotecario della Biblioteca Comunale di Reggio Emilia, e la ristampa anastatica con traduzione italiana della Methodus di Florian Trefler, prototipo cinquecentesco di manuale di biblioteconomia. Ha studiato la cultura e il metodo scientifico dell’agronomo Filippo Re a partire dalla sua biblioteca e dalle sue opere e si è occupato del dattiloscritto e delle schede manoscritte dei Catalogi bibliothecarum Italici Mediae Aetatis di Albano Sorbelli. Ha pubblicato un profilo multidisciplinare di storia dell’educazione fisica e sportiva italiana in età liberale a partire dalle fonti bibliografiche coeve conservate nella Biblioteca Comunale “G. C. Croce” di San Giovanni in Persiceto e dai “materiali minori” bibliografici contenuti nell’Archivio storico della Società Ginnastica Persicetana. Fa parte del comitato di redazione di TECA Testimonianze, editoria, cultura, arte e collabora con AIB Notizie. Ha affrontato anche problemi catalografici e di storia dell'arte, come quello delle origini e delle vicende di Palazzo Bentivoglio a San Giovanni in Persiceto. Dal 2002 al 2019 ha lavorato nella Biblioteca Comunale "G. C. Croce" di San Giovanni in Persiceto (BO) occupandosi tra l'altro di catalogazione di fondi speciali. Lavora attualmente in una delle biblioteche del Comune di Bologna. Fa parte del Comitato Esecutivo Regionale Emilia-Romagna di AIB Associazione Italiana Biblioteche per gli anni 2023-2026.

Giuseppe Olmi
Già professore ordinario di Storia moderna all’Università di Bologna, i suoi principali interessi di ricerca riguardano lo sviluppo della storia naturale e i rapporti arte-scienza nella prima età moderna, la storia del collezionismo, del museo e delle Accademie, la storia delle malattie e delle professioni sanitarie.
Ha inoltre partecipato all’organizzazione e alla stesura del catalogo di importanti mostre quali: Il bello e le bestie. Metamorfosi, artifici e ibridi dal mito all’immaginario scientifico (Rovereto 2004); Il viaggio. Mito e scienza (Bologna 2007); Il cannocchiale e il pennello. Nuova scienza e nuova arte nell’età di Galileo (Pisa 2009); Arcimboldo. Artista milanese tra Leonardo e Caravaggio (Milano 2011); Wunderkammer. Arte, Natura, Meraviglia ieri e oggi (Milano 2013).
È stato invitato a esporre i risultati delle sue ricerche presso numerosi Musei, Università, Biblioteche e Istituzioni di cultura sia italiane (Istituto e Museo di storia della scienza, Firenze; Istituto italiano per gli studi filosofici, Napoli; Fondazione Giorgio Cini, Venezia; Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, Firenze; Centro Studi C.RI.S.I.S, Torino) sia straniere (Ashmolean Museum, Oxford; Center for Advanced Study in the Visual Arts/National Gallery of Art, Washington; Institut für Museumskunde /Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, Berlino; Musée du Louvre, Parigi; Istituto italiano di cultura, Parigi; Natural History Museum, Londra; Reale Accademia delle Scienze, Stoccolma; Tiroler Geschichtsverein, Innsbruck; Università di Ginevra – Escola de Primavera d'Història de la Ciència, Maó; Universidad Internacional Menéndez Pelayo, “Lecturas de la Fundación Marcelino Botín", Santander; Staatliche Kunstsammlungen, Dresda; Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Barcellona).
È socio ordinario dell'"Accademia Nazionale Virgiliana di scienze, lettere ed arti" di Mantova, dell'"Accademia degli Agiati" di Rovereto e della "Società di Studi Trentini di Scienze storiche" di Trento; socio corrispondente dell'"Accademia delle Scienze di Bologna".

Elisa Pederzoli
Dopo la laurea specialistica in Letterature comparate, si è diplomata nel 2014 presso la Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di Stato di Modena e dal 2018 è Cultrice della materia per Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia (M-STO/08) presso l’Università di Bologna.
Nel 2019 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Culture letterarie e filologiche all’Università di Bologna, con una tesi che indaga la storia del libro e dell’editoria della prima metà del Novecento, concentrandosi sull’editore modenese ebreo Angelo Fortunato Formiggini (1878-1938) e sul suo progetto di promozione del libro e della cultura italiana all’estero. Il suo lavoro ha vinto l’edizione 2018 del Premio Giorgio De Gregori dell’AIB ed è stato pubblicato con il titolo “L’arte di farsi conoscere”. Formiggini e la diffusione del libro e della cultura italiana nel mondo (Roma, AIB, 2019).
Dal 2012 al 2020 ha lavorato presso la Biblioteca Estense Universitaria di Modena e ha ricoperto incarichi di docenza per l'insegnamento in inglese di Bibliography and Biblioteconomy presso l'Istituto Marangoni (Firenze), per il corso di studi Art History & Culture.
Da settembre 2020 è responsabile del Servizio Biblioteca e Archivio storico del Comune di Crevalcore (BO).

Chiara Reatti
Ha conseguito il diploma in Archivistica, paleografia e diplomatica all’Archivio di Stato di Bologna nel 2009 e la Laurea magistrale in Scienze storiche all’Università di Bologna nel 2011, con una tesi sul patrimonio archivistico della Biblioteca Capitolare di San Giovanni Battista in San Giovanni in Persiceto (BO), presso la quale collabora come bibliotecaria e archivista dal 2010.
Ha proseguito gli studi all’Università di Udine approfondendo temi di storia del libro e dell’editoria con il Dottorato di ricerca in Scienze bibliografiche, del testo e del documento, ricavando dalla tesi il libro Tra aula e torchio. Libri e scuola a Bologna da Napoleone all’età della Restaurazione (Bologna, Clueb, 2020).
Gli interessi di ricerca spaziano dall’ambito archivistico a quello librario e biblioteconomico in età moderna e contemporanea, con particolare attenzione alla commistione di materiali di natura documentaria e libraria negli archivi e nelle biblioteche.
Ha svolto incarichi di catalogazione presso l’Accademia delle Scienze di Ferrara e lavora alla Biblioteca dell’Abbazia benedettina di San Pietro di Modena, per la quale ha anche curato l’adesione all’Anagrafe dei Beni culturali ecclesiastici e al Polo delle Biblioteche Ecclesiastiche (PBE), che consente la catalogazione in SBN. Per l’anno accademico 2020-2021 è incaricata dell’insegnamento di Archivistica all’Università di Bologna.
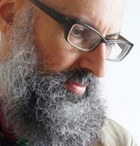
Benito Rial Costas
Benito Rial Costas è Profesor Asociado presso l'Universidad Complutense de Madrid. Il suo lavoro accademico e le sue pubblicazioni interessano principalmente la Bibliografia materiale, la Sociologia dei testi e la storia culturale e letteraria. I suoi interessi di ricerca spaziano dalla cultura e i media del libro, alla ricerca storiografica, bibliografica, alle Digital humanities e alla storia della tipografia. Tra i suoi ultimi lavori figurano Aldo Manuzio en la España del Renacimiento (2019) e il numero monografico della rivista «Quaerendo. A Journal Devoted to Manuscripts and Printed Books» New insights into an old issue: Book historical scholarship on the relationship between the Low Countries and Spain (1568-1648) (2018). Rial Costas è stato più volte Visiting Professor in diverse università, ha tenuto conferenze in università e centri di ricerca europei e americani ed è membro del comitato scientifico di convegni e riviste internazionali, come pure di giurie per l’assegnazione di premi di ricerca.

Francesco Santi
Professore Ordinario di Letteratura Latina Medievale (dal 2000), prima nell’Università del Salento (dove ha coordinato il dottorato europeo in Filologia e letteratura patristica, medievale e umanistica, consorziato con Freiburg i. Br.); poi nell’Università di Cassino (dove ha coordinato il dottorato in Digital Humanities for Medieval Studies) e dal 2019 nell’Università di Bologna. Presidente della S.I.S.M.E.L. e membro del Direttivo della Fondazione Franceschini; co-direttore di CALMA e membro del comitato di direzione di Hagiographica, di Micrologus e del comitato scientifico di Medioevo latino e di Segno e testo. Ha diretto o partecipato a progetti di ricerca nazionali e europei. Ha al suo attivo oltre 300 pubblicazioni (edizioni, monografie e articoli dedicati alla letteratura e alla storia della cultura medievale). Si ricordano L’età metaforica. Figure di Dio e letteratura latina medievale da Gregorio Magno a Dante, Spoleto, CISAM, 2011 e La mistica. Angela da Foligno e Raimondo Lullo. Letteratura Francescana, vol. 5, Milano, Mondadori 2016 (Scrittori greci e latini. Fondazione L. Valla). Dal 2020 è responsabile del progetto di ricerca su Opere anonime e perdute del Medioevo latino (https://site.unibo.it/anonimi-medievali/it) che ha realizzato fra le altre cose una banca dati dedicata a questi testi il volume Pseudo Bonaventura. Studi, edizioni e repertorio (Firenze, SISMEL 2024).

Barbara Sghiavetta
Dopo la laurea in Biblioteconomia e Bibliografia ha collaborato con l'unità di ricerca dell'Università di Bologna al progetto Il testo e le immagini nell'editoria italiana del Settecento. Studiosa di storia dell'editoria ha pubblicato saggi e articoli sulle riviste «Teca» e «Biblioteche oggi» e due monografie: Editoria a testa alta. Le quarte di copertina de "Gli Struzzi" (Pàtron, 2008) e, insieme a Maria Gioia Tavoni, il volume Guida per bibliofili affamati (Pendragon 2014). Negli ultimi anni si è dedicata alla ricerca sulla microeditoria contribuendo all'ideazione e organizzazione di progetti editoriali, mostre e manifestazioni culturali per promuovere la diffusione e la cultura del libro a stampa manuale, dell'editoria artigianale a tiratura limitata e del libro d'artista. Libraia dal 2007 per Librerie.coop, dopo una lunga esperienza di coordinamento dei settori ragazzi e saggistica presso la Libreria Coop Ambasciatori, oggi è responsabile della Libreria Coop Zanichelli.

Anna Sirinian
Professoressa presso l'Università di Bologna dal 2014, svolge le sue ricerche nell'ambito dell'armenistica. I suoi interessi sono rivolti in particolare alla letteratura armena antica e medievale, ai manoscritti armeni, alla storia della presenza armena in Italia e ai documenti relativi agli armeni conservati nelle biblioteche d'Italia. E' docente di riferimento per gli scambi con Università ed enti di ricerca della Repubblica d'Armenia.
E' full member dell'Association Internationale des Etudes Arméniennes (AIEA), socio dell'Associazione Padus-Araxes (Sezione Armenisti Italiani), accademico della Classe sul Vicino Oriente dell'Accademia Ambrosiana e Dottore honoris causa dell'Accademia delle Scienze della Repubblica d'Armenia.
E' co-direttrice della rivista online Armeniaca. International Journal of Armenian Studies (https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni4/riviste/armeniaca/).

Francesca Tomasi
Professoressa di Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia (HIST-04/C) presso il Dipartimento di Filologia classica e Italianistica dell’Università di Bologna. Si occupa di informatica umanistica (Digital Humanities), con particolare attenzione all’edizione digitale di testi e documenti nel solco dei sistemi di organizzazione della conoscenza in archivi e biblioteche.
È direttrice del centro DHARC (Digital Humanities Advanced Research Center) e coordinatrice del Dottorato in Patrimonio Culturale nell'Ecosistema Digitale, entrambi attivi presso l'Università di Bologna.
È stata inoltre Presidente della Biblioteca di Discipline Umanistiche dell'Università di Bologna, Presidente dell'AIUCD (Associazione per l'informatica Umanistica e la Cultura Digitale) e coordinatrice della laurea magistrale DHDK (Digital Humanities and Digital Knowledge).
Fa parte del comitato scientifico delle riviste «Bibliothecae.it», «Biblioteche Oggi Trends», «Umanistica Digitale», «Documenta» e «J-LIS» e dei centri di ricerca ARCE, CERB, DH.ARC, ADLab dell’Università di Bologna.
Insegna “Knowledge Organization in Libraries and Archives” all’interno del corso di laurea magistrale DHDK; “Informatica Umanistica” e “Digital Humanities e patrimonio culturale” nei corsi di laurea triennale e magistrale dell’Università di Bologna.

Paola Vecchi
Già professore ordinario di Filologia della letteratura italiana (Laurea Triennale) e di Letteratura e Filologia italiana (Laurea Magistrale) presso il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica (Facoltà di Lettere e Filosofia) dell’Università di Bologna. Ha insegnato anche presso il Corso di Laurea magistrale interateneo in Culture e tradizioni del Medio Evo e del Rinascimento attivato presso l’Università di Ferrara. Nell’ambito del Dipartimento di Filologia classica e Italianistica dell’Università degli Studi di Bologna, ha occupato e svolge numerosi incarichi: è stata garante del Comitato per l’assegnazione dei fondi ministeriali (RFO, Comitato 10); ha fatto parte della Commissione scientifica che dirige la Biblioteca di Italianistica; dal I ottobre 2007 sino al 2010, è stata Coordinatore del Dottorato in Italianistica. Dal giugno 1999 è Socio residente della Commissione per i Testi di Lingua in Bologna; dal novembre 2014 ne è il Presidente. Dal giugno 2004 fa parte del Consiglio Direttivo del Centro Studi «Matteo Maria Boiardo» ed è membro del Comitato scientifico che coordina la pubblicazione di tutte le opere di Matteo Maria Boiardo. Dal gennaio 2014 è Socio residente corrispondente della Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna. Dal 2008 dirige, con Emilio Pasquini, Alfredo Cottignoli, Vittorio Roda, la rivista scientifica «Studi e problemi di critica testuale». Dal settembre 2011 al 2018 è stata direttore responsabile della nuova rivista di storia del libro e del testo «TECA». Quanto alla sua attività di ricerca, ha partecipato a numerosi Convegni di studio, in Italia e all’estero, e ha collaborato a iniziative culturali che corrispondono a specifiche aree di approfondimento scientifico: si segnalano in particolari gli interventi, filologici e ermeneutici, su Dante e Petrarca, sulla poesia del Tre e Quattrocento, sui metodi e sulle forme di pubblicazione e di interpretazione del testo letterario.